______________________________________________________________________
2015
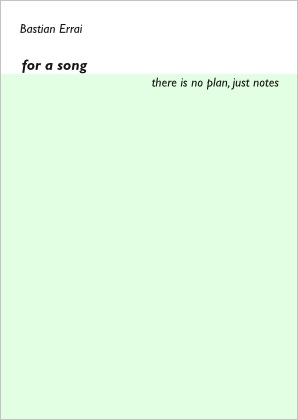
for a song gioca contemporaneamente lucidamente sui due bordi opposti del teatro, saggismo e misticismo. E’ un saggismo paradossale perché non si occupa di niente, non propone effetti straniamento, citazioni, revoche della rappresentazione, sociologie. ”Riflette” (come un bagliore nello specchio) sulle possibilità interne al teatro come rito autosufficiente, come dispositivo rituale che, col tempo, potrebbe anche emanciparsi di quel fenomeno spurio chiamato pubblico. Tre sono le stazioni o attitudini: ambiguità, sfida e estasi. Ambiguità è il preludio come puro mostrare l’instabilità identitaria dell’attore, una volta che gli sia stata tolta la parola, la storia, un contesto. Questo puro mostrarsi dell’attore davanti agli occhi degli spettatori, questo beffardo sfilare è un’ambiguità che diviene immediatamente sfida nel momento in cui finta, finge un preludio, uno sviluppo che non esiste, è solo tempo che scorre sotto le luci di scena, il volto come presente consistente che deflagra per sempre in diretta, è questo presente che si sfilaccia irrimediabilmente lo “spettacolo”. Segue il climax (falso) come sfida, come mimesi di pura gestualità rock, il pubblico si fa cerchio, l’attore “danza” P.J. Harvey, è come Houdini che insolentemente promulgava già l’esito ancor prima che venisse gettato nell’acqua gelata con le mani ammanettate. Il gesto è così violento, così impossibile, così annunciato che all’attore non resta che la morte e al pubblico la spoglia ed è così che la sfida si fa ancora ambiguità. I due tronconi non si ricompongono, è solo qualcosa che non si fa analizzare che giunta i due rushes, il silenzio (anche la musica come soundtrack non la smette con questo silenzio/ sfida, lo amplifica). L’attore non parla, sfida al (il) silenzio, un attore che è finalmente questa intera scena vuota di altro che non sia questa pura dispersione a vuoto di concetti formulabili. Rimane solo uno spazio opaco, un impiantito che stenta nel riflettere qualche luce incerta. E come se questo non fosse ancora sufficiente si fa strada la terza, conclusiva, terribile terza stazione, l’Estasi. Dopo il buio il pubblico entra a gruppi, come una comitiva zoologica in un recinto dove gli attori, isolati come su cabine di lancio di immaginarie navette spaziali si (ri)velano in procinto di un viaggio immobile. Ma è vero? Quest’evidenza mente, gli attori scompaiono in piena luce come in un numero di alta magia. Statuaria pulsionale, ascolto di microimpulsi, cecità dell’attore che ausculta le profondità del corpo-tempo, auto-erotismo, transe. Ciò che conta è che quello che il pubblico guarda è divenuto assente. Ed è così che la “scena” cambia derisoriamente protagonista, il pubblico assume di rimbalzo l’azione che il performer gli ha consegnato in mano come un talismano scaduto, si aggira sotto la luce a picco in una dimora abbandonata, è una gang di voyeurs che si muove smarrita tra le rovine del “Teatro”.
I non più attori tremano, auto-immersi in un flusso di biografie esclusivamente vibratorie. Quella labilità di lineamenti che all’inizio era illusionismo di superfici, mostrarsi e ritrarsi alla luce, ricerca di angolazioni per incontrare lo sguardo, si trova ora in questa prodigiosa fuga negli interni. Quali?
I due corpi a nudo sono nell’altrove, nell’utopia del futuro o nelle lontananze del passato, che importa ormai? Cecità pulsionale o estasi, sisma, sono solo il segnale dello stop alla visione e dell’altrove. Anywhere out of the wor(l)d. Appunto, solo for a song
Paolo Spaziani
______________________________________________________________________
Bastian Errai – (non cercate)

______________________________________________________________________
2014

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
2012
incolti

"Attraverso ciò che resta d'impalpabile, quasi inconsistente,
qui, fra il già e il non ancora,
fra inconcludenze, dispersioni, rinunce,
cosa possiamo nella continua promessa di un inizio?"
Supponiamo uno spettacolo che eviti con cura di trasferirsi piattamente in un “messaggio” ma che abbia tutta la volontà di indicare qualcosa che avviene là, nell’immanenza della scena. Ecco la sfumatura umoristica del titolo, beffardo nel dire un non-sapere (secondo l’accezione di un Georges Bataille), un non volerne sapere di dire niente altro che quello che di carnale avviene in scena. Uno spettacolo tutto costruito su enigmatiche triangolazioni di corpi che giocano tutte le permutazioni possibili di un rapporto essenzialmente musicale, se per musica si intende anche un ascolto visivo che gioca con l’immobilità e il movimento delle figure, campite e poi improvvisamente frantumate in uno spazio sempre mobile che allarga la scena. Un trio reale (due donne, un uomo) responsabili di un’atmosfera-mondo senza che ci sia alle spalle una “storia” che li preceda e informi (li informi) sulle loro azioni, davanti a loro solo questo non-sapere, come spiaggia deserta o locale notturno dopo la chiusura. Ci saranno evidentemente barlumi di rappresentazione, passi di danza, apparizioni di una percezione quasi cinematografica in una durata che si è sbarazzata di ogni riferirsi ad altro che a se stessa, solo attenzione e rarefazione, erotismo. Gli attori evolvono umoristicamente in questa scena disertata da sensi apparenti impugnando brandelli di ruolo e frammenti di testi, testi che figurano quasi da esergo o da commento di questa violenta esibizione di quello che può un corpo. Lirica italiana e francese di ieri o di oggi che diventa quasi blasone araldico o allusione cifrata di qualcosa che invece sfugge, eversivo. E infatti quest’attenzione, questa rarefazione, questo sbriciolare ogni racconto non è affatto citazione-reminescenza vagamente erudita di modi avant-garde, non è mai sfoggiare intellettualisticamente una forma vuota (ritornare ancora beffardamente al titolo) ma nella curva musicale del suo procedere diventa straziante, assurda e tragica protesta per un sapere che il Discorso (che è sempre Discorso di Potere) esclude, non smette di escludere. E’ come se lo spettacolo invece non smettesse di alludere alla singolarità della traiettoria di un corpo, a questo sapere preciso e indicibile, che non si fa dicibile se non per mezzo di una poesia sua propria, se non per mezzo della potenza astratta e carnale del teatro, nemica giurata di ogni discorso di potere (che nega la singolarità, che omologa). Ed ecco che questo spettacolo inventa carnalmente una sua paradossale rappresentazione che è una crittografia di personaggi psichici, di moti interiori, di pulsioni, apparizioni improbabili e crudeli. E’ come se quest’astrazione fosse l’invenzione di un nuovo romanticismo, come se questa rarefazione e rivendicazione di una singolarità fossero l’evocazione di una moltitudine, vista da lontano come un miraggio che consente solo il teatro.
Paolo Spaziani
______________________________________________________________________
2010
